In cover, la torre degli Asinelli e quella della Garisenda, a Bologna, a cui Dante dedicò uno dei suoi primi sonetti © cge2010/Adobestock
Il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna, fondato da Davide Rondoni insieme al professor Ezio Raimondi, in collaborazione con il Comune, ha dato il via al festival Amor gentile - Dante e il parlar d’amore a Bologna. Da giugno, per diversi mesi, gli appuntamenti vedono protagonista il dir d’amore, tra poesia, musica, premi e convocazione libera di poeti.
Si parte il 9 con il premio Nobel Olga Tokarczuk, si prosegue il 16 con un reading di Arnaldo Colasanti, Melania Panico e Sergio Cristaldi; giovedì 17 si premiano Milo De Angelis e il grande poeta cileno Raúl Zurita, mentre il 18 risuonano canzoni d'amore medievali a cura di Giuseppina Brunetti. Sabato 19, invece, una lettura aperta a tutti invita a Bologna chiunque voglia leggere la propria poesia d’amore in pubblico, con gran finale insieme alla Banda Dante dell’Orchestra di musica popolare dell’Auditorium di Roma, David Riondino e altri gruppi musicali.
E poi, ancora, altre conferenze e incontri, con i dantisti Giuseppe Ledda e Giuliano Milani e una serie di incontri sulle donne del Sommo Poeta a cura di Cinzia Demi. Prevista anche la partecipazione di attori e artisti, con spazio ai giovani, e ospiti d’eccezione come Francesco Guccini e Alessandro Preziosi.
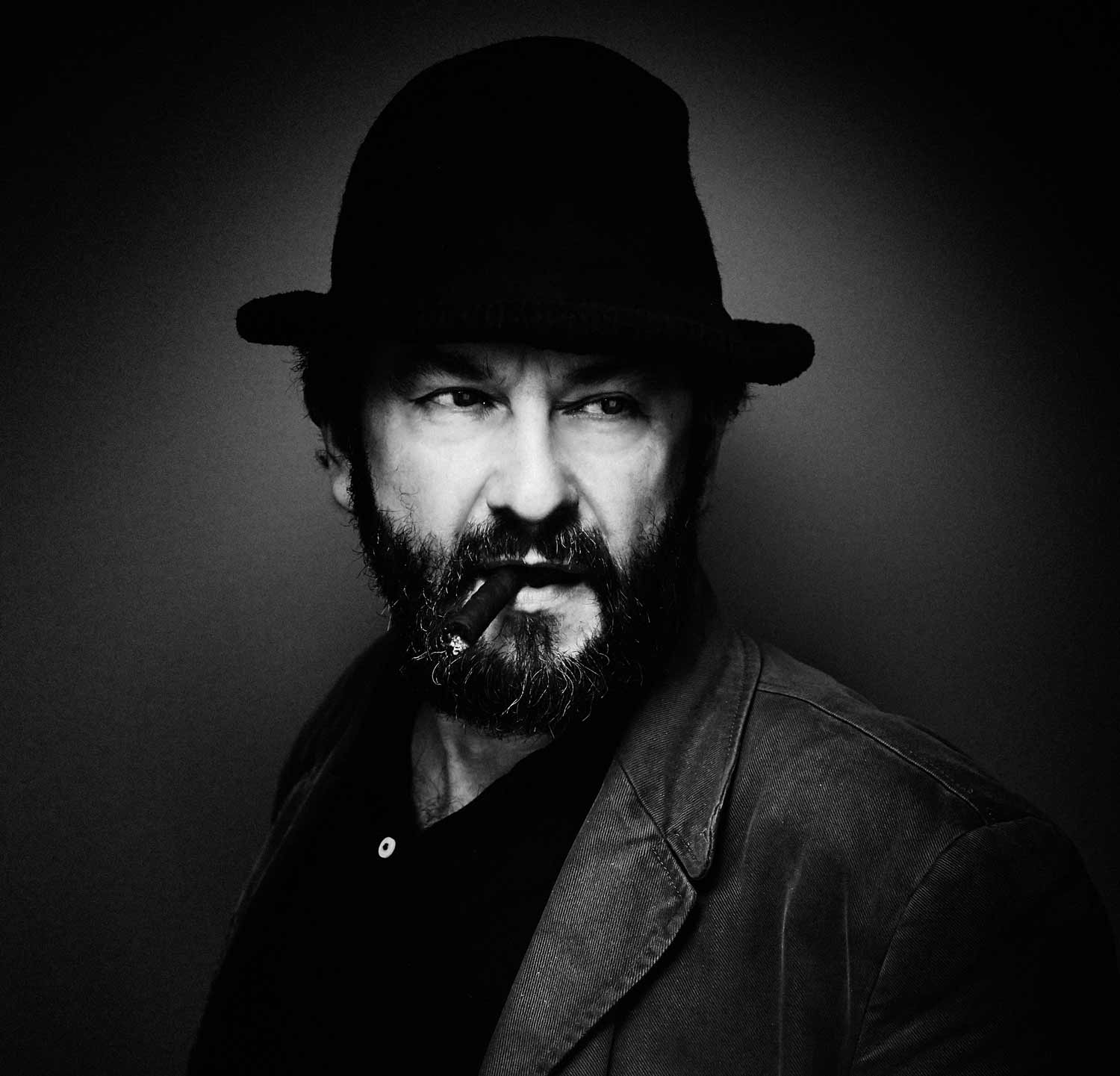
Il poeta e scrittore Davide Rondoni @ Giovanni Gastel
A Bologna per scoprire l’amore. C’è bisogno di riscoprirlo sempre. Perché non è un’idea, una teoria, una ricetta. L’amore muove. Non è un sentimento, ma una forza. Una passione ma anche una dedizione. La nostra epoca è molto sentimentaloide, ma non per questo conosce l’amore. E allora andiamo a Bologna per riscoprirlo.
La notizia è che esiste almeno uno che ha capito cos’è l’amore. La cosa che ci fa diventar matti. La cosa di cui tanti parlano e pochi dicono veramente qualcosa. E che, a ben vedere, fonda la nostra civiltà. Cosa sarebbe l’Italia, l’Europa, senza cultura e civiltà dell’amore? Uno spettro. Lui è il poeta che tutti (anche a vanvera) celebrano quest’anno e che ha scritto per Beatrice (e per tutti) la prodigiosa Commedia.
Nel momento finale del XXXIII canto del Paradiso, quando ritrae per l’ultima volta la ragazza in carne e ossa, storica, che lo ha salutato nella Vita nova e che ha perduto e ritrovato, ce la indica mentre fa un gesto semplice, sperduta nella folla della Rosa Ultima: Beatrice unisce le mani in un amen per lui, perché il suo viaggio si compia fino in fondo. Perché lui possa giungere a vedere il segreto della vita. In quel gesto, in quel così sia, sta la sintesi di cosa è amare una persona: voglio essere un amen per te, un così sia il tuo viaggio, fino in fondo.

È il contrario dell’amore come possesso, come contratto, come gabbia. L’amore vero è un amen, non sopporta i mascheramenti. Non si possiede per amore, non si uccide per amore, non si disprezza per amore. Dante sa che amare una persona è diventare un amen per lei. Il vertice della poesia d’amore sta in quel momento.
Bologna era la città dove Dante si recava per partecipare alla vita poetica dell’importante centro culturale. Si trovava lì con i suoi amici e lì ha scritto il primo testo che conosciamo di lui, un sonetto alla Garisenda, una delle Due Torri. Lì era nato Guido Guinizelli, che nella Commedia lui chiama “padre”. Nato nel 1230, Guinizelli fu iniziatore e fondatore, tra gli ultimi anni del ‘200 e i primi del ‘300, della nuova lirica d’amore conosciuta nella storia della letteratura come Dolce stil novo.
Il nome della scuola deriva dalla definizione data da Dante nel dialogo con Bonagiunta Orbicciani da Lucca (Purgatorio XXIV), secondo il quale l’originalità di questi poeti consiste nel fatto che essi scrivono seguendo diretta ispirazione d’amore.

I motivi del nuovo canto gli stilnovisti li riprendono in parte dall’amor cortese, ma anche da temi neoplatonici e soprattutto cristiani, messi a fuoco nella teologia del tempo, come l’affermazione che la vera nobiltà d’animo non sia nei diritti della nascita e nel censo, ma nella nobiltà interiore di amare qualcuno che non si possiede. Qui si perfeziona la rappresentazione della donna come figura ispiratrice di un amore che è anche elevazione morale e quindi amore per la sapienza; i destinatari della nuova poesia diventano così “cori gentili” legati da un sentimento di amicizia.
In mezzo a tante chiacchiere vuote sull’amore, Bologna offre con arte e bellezza la possibilità di una riflessione e di una condivisione non banale dell’esperienza amorosa. Quanti inutili e vacui contenitori televisivi, quanto ronzio vuoto su media di ogni genere intorno a ciò che ci fa tremare il cuore, a ciò che riguarda in modo così potente e delicato la nostra più intima natura.
Del resto, quando ai ragazzi più giovani si mostra perché Dante abbia scritto la Commedia, cioè per non perdere lei, Beatrice, allora questa grande opera riaccende l’interesse di tutti. Il suo viaggio di conoscenza e amore il poeta lo ha fatto per tutti, per indicare in quel gesto, nel così sia di Beatrice, il modo più adeguato per rappresentare l’esperienza che tutti muove. Insieme al sole e all’altre stelle.
Articolo tratto da La Freccia
La giovane regista Mazlo partecipa al festival del nuovo cinema francese Rendez-vous
09 giugno 2021