
In cover Nicola Lagioia © Chiara Pasqualini
Una narrazione che avviluppa e risucchia come un mulinello d’acqua. Nicola Lagioia ha scritto un libro che non lascia scampo al lettore, lo inchioda a quel flusso di parole che scorre tra le pagine con immagini lucidamente ossessive, slide di una storia cupa di cui, a fatica, se ne accetta la realtà. Al centro de La città dei vivi un fatto di cronaca nera, un appartamento della periferia romana, Manuel Foffo e Marco Prato neanche trentenni che seviziano, fino alla morte, il ventitreenne Luca Varani.
E Lagioia che scava, rivela, descrive, profila stati d’animo, allucinazioni, vuoti cosmici interiori. Si mette a tu per tu con il male senza senso, oltrepassa la soglia del dolore, affonda nel baratro da dove non si può risalire.
Riporta un episodio feroce dei nostri giorni con la maestria del verbo contemporaneo e la densità di una tragedia greca: strazi, efferatezze, maschere, urla del coro, vittime e carnefici. E poi c’è Roma a far da quinta, la città che non finisce mai, che trasuda di potere, delirio, degrado e magnificenza perpetua di cui non si può fare a meno. Tutto in un solo sguardo.
Quattro anni per scriverlo. Com’è nato il tuo ultimo libro?
Ricordo benissimo quella domenica del 6 marzo 2016 quando sentii per la prima volta la notizia al telegiornale. Mi colpì la violenza estrema con cui Varani fu assassinato, non si confaceva a un delitto metropolitano, sembrava una scena di guerra dove il diritto viene sospeso. Un omicidio privo di movente – dicevano – e consumato da persone ritenute normali fino a poco prima. Foffo e Prato non avrebbero mai pensato di essere capaci di tali violenze. Quando si descrivono, durante gli interrogatori, si definiscono degli “spossessati”, quasi avessero agito soverchiati da una forza superiore. I classici concetti di libero arbitrio, autodeterminazione, assunzione di responsabilità, maturazione di una colpa in loro sono saltati. Tutto questo mi ha colpito profondamente, era qualcosa fuori dal comune successa a pochi passi da casa mia. Mi sono avvicinato al caso, fino a starci dentro per oltre quattro anni.
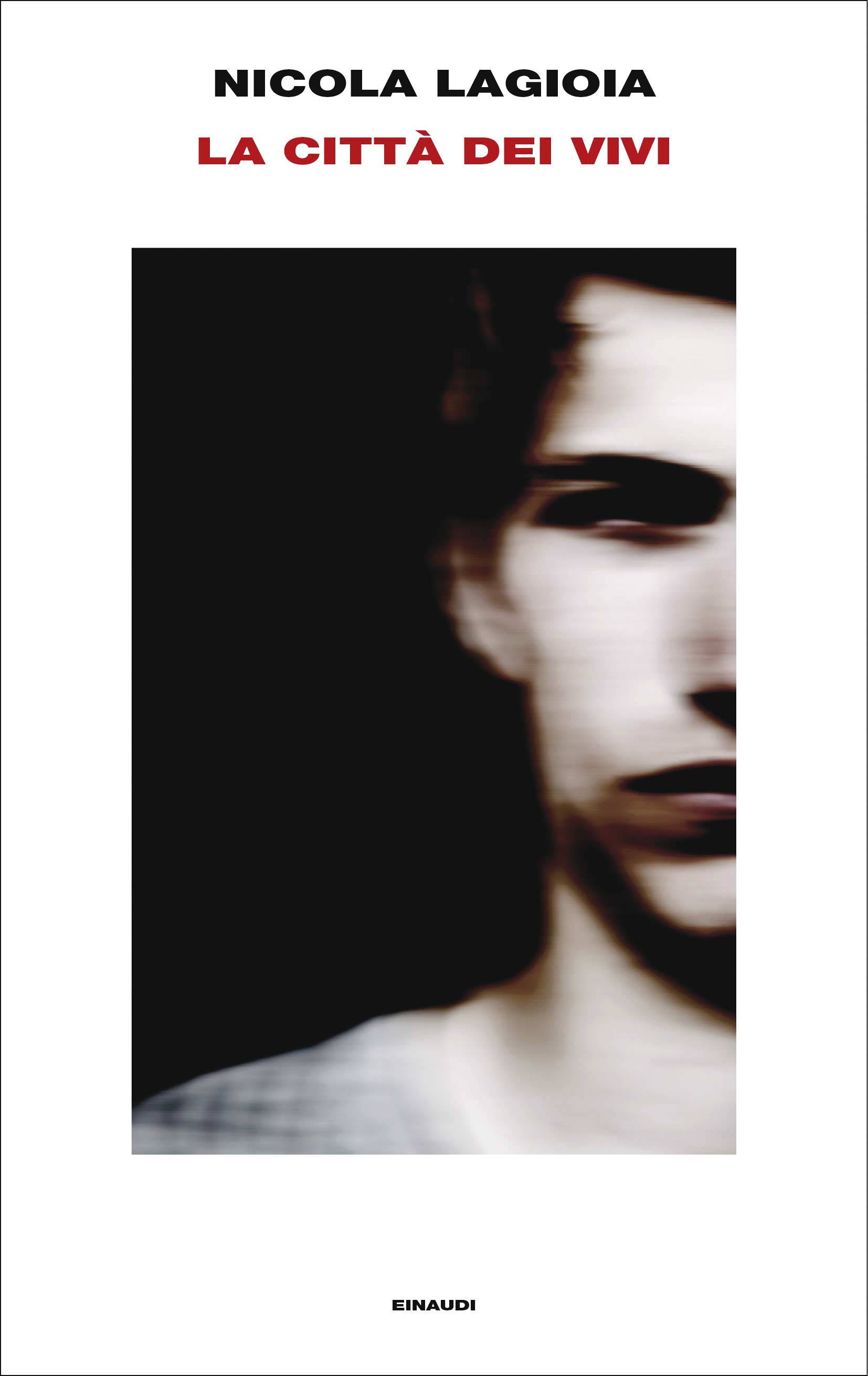
Einaudi, pp. 472 € 22
Un romanzo del reale?
La letteratura del vero ha una tradizione molto antica nel nostro Paese: Carlo Levi con Cristo si è fermato a Eboli, Primo Levi con Se questo è un uomo, Leonardo Sciascia con L’affaire Moro, Annamaria Ortese con Il mare non bagna Napoli, fino ad Alessandro Leogrande a cui il libro è dedicato. Tutti esempi di una produzione che ha illuminato certe vicende altrimenti rimaste al buio. Lo stesso fatto raccontato da uno scrittore, invece che da uno storico, un sociologo o un filosofo, cambia postura. Mi sono inserito in questo filone.
Come hai costruito questa lunga e articolata narrazione?
Ho vagato quattro anni per Roma. Poi ho raccolto materiale, interviste, documenti, seguito il processo, letto gli atti e incontrato persone di tutti i tipi che hanno accettato di parlare con me: spacciatori, senatori, carabinieri, gestori di locali, amici e conoscenti degli assassini o dei genitori della vittima. Ne è venuto fuori un racconto corale. Ho tenuto anche uno scambio epistolare con Foffo, dal carcere.
L’impianto ricorda quello di un dramma antico.
Il tragico, di cui la storia è percorsa, ha in sé il concetto dell’irrimediabilità, elemento che l’uomo moderno non accetta. Siamo portati a pensare che tutto sia controllabile e sfuggiamo a questa idea, ma se togliamo l’irreversibile, e quindi il senso del tragico, rimuoviamo anche la complessità che offre dignità al racconto dell’individuo.
Ti sei fatto un’idea di ciò che è accaduto in quell’appartamento del Collatino?
La letteratura prova a porre delle domande, non può dare risposte. Questo libro è un incontro a due, tra lo scrittore che mette insieme tutta una serie di elementi e il lettore che prova a interpretarli per trarre le sue conclusioni. Io non offro soluzioni, faccio però emergere la profonda solitudine dei due omicidi: persone che fanno molta fatica a distogliersi da loro stessi, incapaci di costruirsi un’identità e travolti con violenza dal giudizio esterno. Foffo e Prato sono dotati di una debolezza colpevole, questa è l’idea che mi sono fatto.
Tracci fondali umani da cui è difficile risalire. Siamo spacciati?
L’essere umano è una creatura fragile, imperfetta e stupida, un legno storto che la letteratura non ha la pretesa di raddrizzare. Nessun tribunale tra le righe, ma una restituita umanità alle storie, per il solo fatto di metterle in scena nella varietà. Saremmo persi se fossimo solo bianchi o neri invece di accettarci con i nostri colori, le contraddittorietà e le ambiguità. La colpa di Foffo e Prato forse è stata quella di non essere riusciti a chiedere aiuto.
Roma è descritta in maniera corposa come Capitale degli umori densi, la città dei vivi, appunto.
È la grande e antica metropoli in cui sfacelo e bellezza si mescolano senza soluzione di continuità. È bifronte: invivibile e vivibile al tempo stesso. Cinica in maniera insopportabile, per cui qualsiasi cosa tu stia facendo non ne vale mai la pena. Ma l’altra faccia della medaglia è la sua grande saggezza, la consapevolezza che tutto passa e transita, che la gloria è effimera. Nel suo mondo di mezzo le classi sociali sono molto permeabili, povertà e ricchezza si amalgamano: lì tutti hanno la possibilità di incontrare chiunque. A Roma lo splendore riserva la minaccia.
Il tuo prossimo viaggio?
Mi muovo sempre, anche se per un po’ di tempo non credo si possa andare lontano e non prevedo ancora spostamenti senza mascherina. Sarà un viaggio metropolitano.
Si chiude un anno davvero faticoso. Come te lo immagini il prossimo e come trascorrerai il Natale?
Chissà cosa succederà. Il poeta Paul Valéry diceva: «Non esiste più il futuro di una volta», riferendosi a quello remoto. Oggi il domani si è accorciato ancora di più, non sappiamo cosa accadrà tra qualche giorno. A Natale ce ne staremo a casa con i nostri cari, spero, a viverci il presente. Con i libri aperti.
Articolo tratto da La Freccia